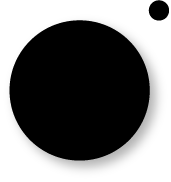L'intervista con Daniele Santucci e Benedetta Mariani rivela una Roma che sfugge alle semplificazioni cartografiche e ai modelli urbanistici tradizionali. La città emerge come un organismo complesso dove la densità assume significati paradossali: quartieri popolosi ma privi di servizi, centralità che non coincidono con il centro storico, flussi di mobilità che raccontano una metropoli diversa da quella immaginata dai piani regolatori.
-
Il concetto di densità che emerge dall'intervista trascende completamente la dimensione quantitativa. Santucci ci invita a considerare come alcuni quartieri romani, pur avendo concentrazioni abitative elevatissime, non generino quella qualità urbana che ci si aspetterebbe. È il caso emblematico della Sapienza, con i suoi 100.000 studenti costretti a spostarsi quotidianamente in motorino o automobile, frammentando l'esperienza urbana in una miriade di tragitti individuali.
Questa osservazione si traduce metodologicamente in un approccio che potremmo definire "densità qualitativa data-driven". Non si tratta più di contare abitanti per chilometro quadrato, ma di costruire un indice composito che integri la presenza di servizi, l'accessibilità del trasporto pubblico, la qualità degli spazi pubblici, le opportunità di interazione sociale. La densità diventa così un dato vivo, pulsante, che racconta storie di quartieri che funzionano come "città nella città" - Trieste, San Giovanni - e di altri che invece disperdono energia e relazioni in spostamenti continui e faticosi.
-
L'insistenza di Santucci sui dati dei flussi apre una prospettiva metodologica fondamentale. Roma non è quella che vediamo nelle mappe statiche, ma quella che si manifesta nei movimenti quotidiani di milioni di persone. I flussi dai Castelli Romani, le congestioni sulle consolari, i pattern di mobilità casa-lavoro rivelano una geografia urbana alternativa, fatta di corridoi di movimento che ignorano i confini amministrativi.
Metodologicamente, questo si traduce nell'integrazione di dataset dinamici - dai dati TIM sui movimenti cellulari alle analisi origine-destinazione in tempo reale - che permettono di visualizzare la città come un sistema in continuo movimento. L'anello ferroviario, tanto celebrato nel bando, emerge dall'intervista come insufficiente, troppo centrale per essere davvero elemento di ricucitura metropolitana. La vera sfida è pensare oltre, verso quelle infrastrutture di connessione che potrebbero trasformare il raccordo anulare da barriera a cerniera urbana.
-
Particolarmente illuminante è la riflessione sui landmark alternativi. Quando Santucci identifica come punti di riferimento non i monumenti ma i quartieri densi, l'orografia, i grandi eventi come le partite allo stadio, sta proponendo una lettura della città che parte dal vissuto quotidiano piuttosto che dalla cartolina turistica.
Questa intuizione si traduce in una metodologia di mappatura che integra dati quantitativi - densità di utilizzo, flussi eventi, concentrazioni di attività - con analisi qualitative delle percezioni e delle pratiche d'uso. Monte Mario che separa, la Nomentana sopraelevata che definisce un'identità territoriale, lo stadio che genera enormi flussi periodici: sono questi i veri organizzatori dello spazio urbano romano, molto più delle piazze barocche.
-
L'esempio dell'app di Zurigo citato nell'intervista non è solo un dettaglio tecnologico, ma rappresenta un cambio di paradigma nella relazione tra dati urbani e sviluppo. La possibilità di accedere in tempo reale a informazioni catastali, normative, simulazioni di fattibilità trasforma il dato da risorsa amministrativa a infrastruttura abilitante per investimenti e trasformazioni.
Nel contesto romano, caratterizzato da opacità burocratica e complessità normativa, una piattaforma di questo tipo non sarebbe solo uno strumento tecnico ma un vero atto politico di apertura e trasparenza. Metodologicamente, questo significa progettare non solo la raccolta e l'analisi dei dati, ma anche la loro comunicazione e accessibilità, creando interfacce che permettano a investitori, progettisti e cittadini di navigare la complessità urbana con strumenti adeguati.
-
La discussione sui cunei verdi che penetrano nella città rivela un'altra dimensione metodologica cruciale. Questi spazi, che Santucci descrive come grandi risorse compromesse dalla congestione del traffico, rappresentano un'infrastruttura potenziale di connessione ecologica e sociale che attende solo di essere attivata.
L'approccio data-driven qui si arricchisce di layer ambientali - dalle immagini satellitari che mappano la copertura vegetale ai dati sulla qualità dell'aria - ma anche di analisi dei flussi di fruizione, delle barriere infrastrutturali da superare, delle potenzialità di connessione con la mobilità dolce. Il Parco dell'Appia diventa modello non solo per la sua qualità paesaggistica, ma per la sua capacità di creare continuità in un tessuto urbano frammentato.
-
Forse l'insight più potente dell'intervista è l'invito a superare definitivamente la dicotomia centro-periferia. Santucci e Mariani ci mostrano una Roma fatta di centralità multiple, alcune consolidate, altre latenti, che attendono solo di essere riconosciute e potenziate.
Metodologicamente, questo richiede un ripensamento radicale degli strumenti di analisi e pianificazione. Non più modelli radiocenttrci, ma network analysis che identifichino nodi e connessioni; non più gerarchie rigide, ma gradienti di intensità e specializzazione; non più confini netti, ma zone di transizione e ibridazione. I dati diventano così strumenti per rivelare potenzialità nascoste - come nel caso delle borgate spontanee che Santucci paragona alle favelas studiate dal MIT, dove meccanismi di auto-organizzazione generano forme urbane vitali anche se non pianificate.
-
Forse l'insight più potente dell'intervista è l'invito a superare definitivamente la dicotomia centro-periferia. Santucci e Mariani ci mostrano una Roma fatta di centralità multiple, alcune consolidate, altre latenti, che attendono solo di essere riconosciute e potenziate.
Metodologicamente, questo richiede un ripensamento radicale degli strumenti di analisi e pianificazione. Non più modelli radiocenttrci, ma network analysis che identifichino nodi e connessioni; non più gerarchie rigide, ma gradienti di intensità e specializzazione; non più confini netti, ma zone di transizione e ibridazione. I dati diventano così strumenti per rivelare potenzialità nascoste - come nel caso delle borgate spontanee che Santucci paragona alle favelas studiate dal MIT, dove meccanismi di auto-organizzazione generano forme urbane vitali anche se non pianificate.
-
L'intervista, nella sua ricchezza di spunti e contraddizioni, ci mostra come la vera sfida metodologica non sia raccogliere più dati, ma integrarli in una visione coerente che rispetti la complessità urbana senza semplificarla. Il framework data-driven deve essere abbastanza robusto da gestire informazioni quantitative precise - flussi, densità, indicatori economici - ma anche abbastanza flessibile da incorporare dimensioni qualitative - percezioni, identità, pratiche d'uso.
In questo senso, la metodologia che emerge è necessariamente ibrida: computazionale e narrativa, analitica e progettuale, globale e locale. È una metodologia che usa i dati non come fine ma come mezzo per comprendere e trasformare una città che, come ci ricorda Santucci, continua a sorprendere con la sua capacità di generare vita urbana anche nelle condizioni più improbabili.
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA
✦
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA ✦