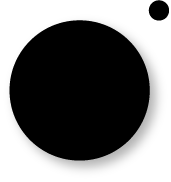L'intervista sulla salute pubblica con il professor Tommaso e il professor Carrara dipinge un quadro sanitario romano caratterizzato da una profonda contraddizione: da un lato, la presenza di eccellenze storiche e competenze di altissimo livello; dall'altro, una frammentazione sistemica che impedisce al sistema di funzionare come rete integrata. Questa tensione tra potenziale e realtà offre spunti metodologici cruciali per ripensare la sanità romana in chiave data-driven e territoriale.
-
L'analisi del professor Tommaso sulla distribuzione degli ospedali romani rivela come la geografia sanitaria sia in realtà una cartografia delle disuguaglianze urbane. Il settore Sud-Est della città emerge come particolarmente sguarnito, mentre le aree centrali concentrano strutture di eccellenza. Questa disparità non è solo quantitativa ma qualitativa: la distanza da un ospedale non si misura solo in chilometri ma in tempo di percorrenza, accessibilità dei trasporti, qualità dei servizi offerti.
Metodologicamente, questo richiede un approccio che integri dati geospaziali con analisi dei flussi di mobilità sanitaria. Non basta mappare dove sono gli ospedali, ma capire come i cittadini si muovono per accedervi, quali barriere incontrano, quanto tempo impiegano. I dati TIM sui movimenti potrebbero rivelare pattern di mobilità sanitaria che raccontano storie di disuguaglianza invisibili nelle statistiche ufficiali.
-
La discussione sul Policlinico Umberto I è particolarmente illuminante. Il professor Tommaso lo descrive come un'istituzione in declino che tuttavia mantiene un ruolo simbolico e funzionale centrale per i romani. La sua proposta - liberare i 31 edifici dalle attività assistenziali per creare un ospedale moderno interno al complesso, mantenendo gli spazi storici per ricerca e didattica - offre un modello metodologico replicabile.
Questo approccio suggerisce che la rigenerazione sanitaria non debba necessariamente passare per la delocalizzazione o la costruzione ex novo, ma possa avvenire attraverso una riconfigurazione intelligente degli spazi esistenti. I dati potrebbero guidare questa trasformazione: analisi dei flussi interni, mappatura delle inefficienze spaziali, simulazioni di riorganizzazione funzionale.
-
Il quadro desolante della medicina di base - medici che lavorano poche ore, riluttanza alle visite domiciliari, disconnessione dal sistema ospedaliero - paradossalmente apre spazi di innovazione. Il PNRR con le sue 600 case di comunità e 300 ospedali di comunità rappresenta un'opportunità, ma solo se interpretato attraverso una logica territoriale data-driven.
L'integrazione nel nostro framework richiede di pensare queste strutture non come entità isolate ma come nodi di una rete. Ogni casa di comunità dovrebbe essere posizionata sulla base di analisi precise: densità di popolazione anziana, presenza di patologie croniche, accessibilità ai trasporti, distanza dagli ospedali. I dati sanitari georeferenziati potrebbero identificare i "deserti sanitari" dove l'intervento è più urgente.
-
La riflessione sugli anziani solleva una questione fondamentale che va oltre la sanità: come ripensare l'invecchiamento in chiave urbana? La proposta di superare il modello delle RSA isolate per creare quartieri age-friendly dove gli anziani possano vivere integrati nella comunità, con servizi al piano terra e spazi di socializzazione, richiede un ripensamento radicale.
Metodologicamente, questo significa integrare dati demografici sull'invecchiamento con analisi urbanistiche sulla qualità degli spazi pubblici, la presenza di servizi di prossimità, l'accessibilità pedonale. Le periferie, indicate come luogo ideale per queste sperimentazioni, potrebbero diventare laboratori di innovazione sociale se supportate da un'analisi data-driven dei bisogni reali.
-
Il tema della mobilità emerge come elemento critico: ambulanze bloccate nel traffico, difficoltà di accesso agli ospedali, tempi di percorrenza che possono fare la differenza tra vita e morte. Questo collega direttamente la pianificazione sanitaria a quella dei trasporti, suggerendo che non si possa pensare alla salute pubblica senza considerare la mobilità urbana.
L'integrazione richiede di sovrapporre mappe sanitarie e di mobilità: dove sono i colli di bottiglia? Quali percorsi seguono le ambulanze? Come ottimizzare i tempi di risposta? I dati real-time sul traffico potrebbero essere integrati con algoritmi di routing dinamico per le emergenze sanitarie.
-
L'analisi comparativa tra sanità pubblica e privata rivela inefficienze strutturali del sistema pubblico che vanno oltre la semplice questione economica. Il privato riesce a gestire casi complessi con il 30% di costi in meno non solo per maggiore efficienza gestionale, ma per una diversa organizzazione del lavoro e degli spazi.
Questo suggerisce che il data-driven approach non debba limitarsi a mappare l'esistente ma possa identificare best practices trasferibili dal privato al pubblico. Quali modelli organizzativi funzionano? Come possono essere adattati al contesto pubblico? I dati potrebbero guidare un processo di benchmarking costruttivo.
-
La visione che emerge è quella di un sistema sanitario che superi la frammentazione attraverso l'integrazione territoriale. Non più ospedali isolati e medicina di base disconnessa, ma una rete dove ogni nodo - dall'ospedale di eccellenza alla casa di comunità, dal medico di famiglia all'assistenza domiciliare - sia parte di un sistema intelligente e adattivo.
Il framework data-driven diventa così strumento non solo di analisi ma di progettazione: identificare gap, ottimizzare risorse, prevedere bisogni futuri, monitorare risultati. La sanità romana può trasformarsi da sistema frammentato a rete resiliente, ma solo se guidata da una visione sistemica supportata dai dati.
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA
✦
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA ✦