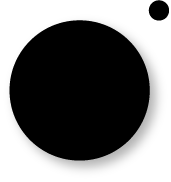L'intervista con la Cooperativa Roma Solidarietà, braccio operativo della Caritas di Roma, introduce una dimensione sociale profonda che trasforma radicalmente la comprensione delle dinamiche urbane romane. Non si tratta più di mappare semplicemente dove sono i poveri, ma di comprendere come la povertà abitativa sia diventata un fenomeno trasversale che attraversa l'intera città, generando nuove forme di esclusione e richiedendo risposte innovative che superino la logica emergenziale.
-
La testimonianza della Caritas rivela una realtà controintuitiva: la povertà abitativa non è confinata nelle periferie ma permea l'intero tessuto urbano. L'esempio del Municipio XV, con il PIL più alto di Roma ma con evidenti difficoltà relazionali e abitative, demolisce ogni stereotipo sulla distribuzione spaziale del disagio. Questa "povertà dei ricchi" - quartieri con muri, guardianie, spazi chiusi dove non si conosce il vicino - rappresenta una forma di marginalità relazionale che richiede interventi specifici.
I processi di gentrificazione emergono come forza devastante che ridisegna la geografia sociale: Centocelle vede raddoppiare i prezzi immobiliari in 10 anni con l'arrivo della Metro C, Trastevere e Testaccio perdono i residenti storici sostituiti da turisti e city users. Questa dinamica di espulsione crea una città che si svuota di diversità sociale, impoverendosi culturalmente mentre si arricchisce economicamente.
Metodologicamente, questo richiede un approccio data-driven che mappi non solo dove sono i poveri oggi, ma dove saranno domani: quali quartieri sono a rischio gentrificazione? Dove si stanno creando nuove sacche di marginalità? Come anticipare e mitigare questi processi? I 250 centri d'ascolto parrocchiali della Caritas rappresentano una rete di sensori sociali preziosissima, capace di rilevare in tempo reale le trasformazioni del tessuto sociale.
-
La strategia dell'Housing First rappresenta un cambio di paradigma fondamentale: non più grandi strutture di accoglienza che ghettizzano, ma appartamenti diffusi in contesti condominiali normali, da Ostia al centro fino all'estrema periferia. Questo approccio trasforma l'assistenza in percorso di autonomizzazione, creando le condizioni per una vera inclusione sociale.
L'integrazione nel framework data-driven permette di ottimizzare questa strategia: dove localizzare gli appartamenti per massimizzare le opportunità di integrazione? Quali mix di tipologie di beneficiari (senza dimora, famiglie, migranti) favoriscono la coesione? Come monitorare i percorsi di autonomizzazione per identificare criticità e best practices? I dati possono guidare una distribuzione strategica che bilanci accessibilità ai servizi, opportunità lavorative, reti di supporto sociale.
Il modello del "piccolo cohousing" introduce inoltre una dimensione comunitaria innovativa: non singoli appartamenti isolati ma micro-comunità che si supportano reciprocamente, creando quella rete sociale fondamentale per il successo dei percorsi di inclusione.
-
Il processo di recupero dei beni ecclesiastici sottoutilizzati, nato dall'enciclica papale del 2015, rappresenta un modello unico di attivazione dal basso. Non un censimento calato dall'alto ma un movimento spontaneo di parrocchie e congregazioni che si attivano per rispondere ai bisogni del territorio. Questo processo, ora strutturato con finanziamenti europei, 8x1000 e supporto della prefettura, dimostra come l'innovazione sociale possa nascere dalla società civile.
L'integrazione con il framework richiede di mappare questo patrimonio diffuso, valutarne il potenziale trasformativo, identificare le sinergie possibili. Una chiesa dismessa può diventare casa di comunità, centro culturale, spazio di coworking sociale. Il ruolo di tutoraggio della Cooperativa Roma Solidarietà è fondamentale: non lasciare sole le realtà che vogliono attivarsi ma accompagnarle con competenze tecniche e gestionali.
-
I 250 centri d'ascolto parrocchiali rappresentano un'infrastruttura sociale unica, capillare come nessun servizio pubblico. Sono "antenne sui territori" capaci di intercettare bisogni emergenti, trasformazioni sociali, nuove forme di povertà. Il progetto "Fatti di Rete" che li connette crea una intelligenza collettiva preziosa per comprendere le dinamiche urbane.
Metodologicamente, questa rete può essere potenziata attraverso strumenti digitali che permettano di aggregare e analizzare in tempo reale i dati raccolti. Non solo statistiche ma narrazioni, non solo numeri ma storie che rivelano le trasformazioni profonde della città. L'integrazione con il portale OSP del Comune di Roma crea inoltre sinergie istituzionali fondamentali.
-
L'aspetto più innovativo dell'approccio Caritas è il superamento della logica emergenziale verso interventi strutturali. Non si tratta più di dare un tetto e un pasto ma di "contribuire a modificare l'assetto della città proponendo soluzioni diverse sull'abitare". Questo richiede una visione di lungo periodo, investimenti in accompagnamento sociale, costruzione di reti di supporto durature.
La progettazione partecipata, con tavoli che includono beneficiari, enti del terzo settore, istituzioni, rappresenta un modello di governance inclusiva. I senza dimora non sono oggetto di intervento ma soggetti attivi nella definizione delle soluzioni. Questo approccio si allinea perfettamente con la dimensione antropologica emersa nelle altre interviste, valorizzando saperi esperienziali e competenze non formali.
-
La riflessione sulle "nuove povertà" - non più il clochard stereotipato ma famiglie, giovani coppie, lavoratori precari - richiede risposte sistemiche. La povertà abitativa si intreccia con quella lavorativa, relazionale, sanitaria in modi complessi che richiedono interventi integrati. Il centro studi della Cooperativa, con la sua tradizione di ricerca dagli anni '80, rappresenta un patrimonio di conoscenza fondamentale per comprendere queste trasformazioni.
L'integrazione nel framework richiede di superare approcci settoriali per una visione olistica: come l'housing si connette con la mobilità? Come l'inclusione abitativa favorisce quella lavorativa? Come i servizi sanitari territoriali possono integrarsi con quelli sociali? Le risposte a queste domande richiedono quella multidisciplinarietà che caratterizza l'approccio della Cooperativa.
-
La presenza storica della Caritas in aree diverse - da Ostia a Villa Glori, da Termini a Pigneto - rivela come ogni territorio richieda approcci specifici. Non esiste un modello unico di intervento ma una capacità di adattamento al contesto che valorizza specificità locali e risorse territoriali. L'Idroscalo di Ostia con le sue strade che diventano fiumi di fango richiede interventi diversi dal quartiere dei Parioli con le sue solitudini dorate.
Questa sensibilità territoriale si integra perfettamente con l'approccio place-based del progetto complessivo. Ogni intervento deve essere calibrato sulle specificità del luogo, valorizzando risorse esistenti e costruendo sui punti di forza locali. La memoria storica della Cooperativa, incarnata da figure come Riccardo, diventa risorsa preziosa per non ripetere errori e valorizzare successi.
-
L'ammissione che si tratta di "approcci innovativi ancora in fase di sperimentazione" rivela un'umiltà metodologica preziosa. Non si pretende di avere tutte le risposte ma si sperimenta, si monitora, si adatta. Questo approccio learning by doing si allinea perfettamente con la logica del living lab urbano, dove la città diventa laboratorio di innovazione sociale continua.
L'integrazione con il framework data-driven non deve irrigidire questa flessibilità ma potenziarla: i dati servono per imparare più velocemente, per identificare cosa funziona e replicarlo, per correggere rapidamente gli errori. La valutazione di impatto sociale diventa così non controllo burocratico ma strumento di apprendimento collettivo.
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA
✦
TUTTO INIZIA CON UN'IDEA ✦